Caranx lugubris Poey, 1860

(Da: en.wikipefdia.org)
Phylum: Chordata Haeckel, 1874
Subphylum: Vertebrata Lamarck J-B., 1801
Classe: Actinopterygii Klein, 1885
Ordine: Perciformes Bleeker, 1859
Famiglia: Carangidae Rafinesque, 1815
Genere: Caranx Lacepède, 1801
English: Black jack, Black trevally, Black kingfish
Français: Carangue noire
Español: Jurel negro, Tiñosa
Descrizione
È un pesce di grandi dimensioni, ed è noto con sicurezza che cresce fino a una lunghezza di 1 m e un peso di 17,9 kg, sebbene sia più comune a lunghezze inferiori a 70 cm. Almeno una fonte afferma che è stato segnalato un pesce di 2,21 m, che se fosse vero lo renderebbe la seconda specie di carangide più grande dietro la ricciola dalla coda gialla (2,5 m). Ha una forma corporea complessivamente simile agli altri membri di Caranx , avendo una forma oblunga e compressa, con il profilo dorsale più convesso del profilo ventrale. Questa convessità è più pronunciata alla testa, che degrada ripidamente verso il basso, conferendo al profilo della testa un aspetto molto spigoloso. Il profilo tra il muso e la nuca è concavo, con questa rientranza centrata vicino alle narici. La bocca è abbastanza grande rispetto ad altri membri del suo genere e la mascella si estende sotto il centro dell'occhio del pesce. La mascella superiore contiene una serie di forti canini esterni con una fascia interna di denti più piccoli, mentre la mascella inferiore contiene una singola fila di denti conici ampiamente distanziati. La pinna dorsale è in due sezioni; il primo ha 8 spine e la seconda 1 spina e da 20 a 22 raggi molli. La pinna anale ha 2 spine staccate anteriormente e da 16 a 19 raggi molli. I lobi delle pinne dorsali e anali sono allungati. Le pinne pelviche contengono 1 spina dorsale e 21 raggi molli, mentre le pinne pettorali sono falcate e più lunghe della testa. La linea laterale ha un'arcata anteriore pronunciata e moderatamente lunga, con la sezione curva che interseca la sezione diritta sotto il lobo della seconda pinna dorsale. Il peduncolo caudale ha anche chiglie bilaterali accoppiate. Il torace è completamente ricoperto di squame, che come il resto del corpo sono piccole e di natura cicloide. La specie ha da 23 a 30 branchie branchiali in totale e sono presenti 24 vertebre. Il corpo è di un colore uniforme da oliva a marrone, grigio e persino nero lungo la schiena che schiarisce in un grigio-blu vicino alla parte inferiore del pesce. Le pinne vanno dal grigio al nero e gli scuti sono neri. Il limite superiore dell'opercolo presenta spesso una piccola macchia scura, solitamente più piccola della pupilla. Vive sia in solitudine che in gruppo fino a 30 individui. Come molti suoi simili è in grado di coordinare queste aggregazioni sulle barriere coralline in base al rilascio di dimetilsolfoniopropionato (DMSP) dalla barriera stessaa. Il DMSP è una sostanza chimica presente in natura prodotta dalle alghe marine e, in misura minore, dai coralli e dalle loro zooxantelle simbionti. In Atlantico la specie è stata anche videoregistrata la Seriola rivoliana, e la Seriola dumerili. La dieta della specie è stata segnalata in due occasioni; una volta dall'Isola di Pasqua nel Pacifico meridionale, dove consisteva principalmente di pesci e crostacei compresi stomatopodi e isopodi; e dal Brasile, dove si prelevava una varietà di pesci, crostacei e molluschi. C'è anche qualche suggerimento che in Brasile la specie possa essere in competizione per il cibo con il dentice rosso, Lutjanus campechanus, con entrambi con diete quasi identiche. È anche noto per seguire i delfini spinner per nutrirsi dei loro escrementi. La storia della vita della specie è stata determinata in parte dalle acque della Giamaica. Qui i rapporti tra maschi e femmine sono stati riportati come 1:0,55, indicando che i maschi sono quasi due volte più comuni delle femmine. Raggiunge la maturità sessuale a 34,6 cm nelle femmine e 38,2 cm nei maschi. Il momento della deposizione delle uova è poco noto, con occorrenze registrate in febbraio, aprile, maggio e da luglio a settembre. Il comportamento riproduttivo e la prima storia di vita della specie sono del tutto sconosciuti. L'analisi delle catture suggerisce che la lunghezza media del pesce è di 50 cm per i maschi e di 48 cm per le femmine.
Diffusione
Ha una distribuzione circumtropicale, il che significa che la sua gamma si estende intorno agli oceani equatoriali della Terra, abitando così le regioni tropicali e subtropicali degli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano. Nell'Oceano Indiano si trovano da Natal, in Sud Africa a ovest, fino all'Australia settentrionale a est. Sono distribuiti in modo irregolare lungo la costa orientale dell'Africa e dell'Asia nell'Oceano Indiano, essendo assenti sia dal Golfo Persico che dal Mar Rosso, nonché da diversi paesi che si affacciano sull'oceano. La specie è ampiamente conosciuta da molte isole dell'Oceano Indiano comprese le Seychelles, Réunion, Mauritius e Cargados Carajos. Nell'Oceano Pacifico, il black jack è conosciuto da parti dell'arcipelago indonesiano-australiano a nord del Giappone, e attraverso molte delle isole del Pacifico come Hawaii , Nuova Caledonia e Tonga. La gamma di specie nel Pacifico orientale è stata varia dal Messico e dalle isole Revillagigedo a nord al Costa Rica a sud. Nell'Oceano Atlantico occidentale, sono stati trovati dalla Carolina del Nord negli Stati Uniti a sud fino a Rio de Janeiro, con le specie più comuni nei Caraibi e nel Golfo del Messico settentrionale. Nell'Atlantico orientale, la specie è stata segnalata dalle Azzorre, dalle rocce di Madeira St. Paul, dall'isola dell'Ascensione e dal Golfo di Guinea. È una specie bentopelagica che si trova raramente in acque costiere poco profonde, prediligendo acque offshore profonde e limpide di profondità da 12 a 354 m. La specie è più comune negli habitat oceanici insulari e intorno alle isole al largo, raramente si trovano vicino ai continenti. Il black jack abita le barriere coralline profonde e i drop off della barriera corallina, essendo comune anche intorno alle montagne sottomarine oceaniche. È stato registrato nelle lagune delle Isole Salomone.
Sinonimi
= Caranx ascensionis Cuvier, 1833 = Caranx frontalis Poey, 1860 = Caranx ishikawai Wakiya, 1924 = Caranx tenebrosus Jordan, Evermann & Wakiya, 1927.
Bibliografia
–Smith-Vaniz, W.F.; Williams, J.T.; Pina Amargos, F.; Curtis, M. & Brown, J. (2017) [errata version of 2015 assessment]. "Caranx lugubris". IUCN Red List of Threatened Species. 2015.
–J. S. Nelson; T. C. Grande; M. V. H. Wilson (2016). Fishes of the World (5th ed.). Wiley. pp. 380-387.
–Smith-Vaniz, W.; Randall, J. (1994). "Scomber dentex Bloch & Schneider, 1801 (currently Caranx or Pseudocaranx dentex) and Caranx lugubris Poey, [1860] (Osteichthyes, Perciformes): proposed conservation of the specific names". Bulletin of Zoological Nomenclature. 51 (4): 323-330.
–Poey, F. (1860). Memorias sobra la historia natural de la Isla de Cuba, acompañadas de sumarios Latinos y extractos en Francés. Vol. 2. Havana. pp. 97-336.
–Online Etymology Dictionary (2001). "lugubrious".
–Hosese, D.F.; Bray, D.J.; Paxton, J.R.; Alen, G.R. (2007). Zoological Catalogue of Australia Vol. 35 (2) Fishes. Sydney: CSIRO. p. 1150.
–International Commission on Zoological Nomenclature (1996). "Scomber dentex Bloch and Schneider, 1801 (currently Caranx or Pseudocaranx dentex) and Caranx lugubris Poey, (1860) (Osteichthyes, Perciformes): Specific names conserved". Bulletin of Zoological Nomenclature. 53 (2): 140-14.
–Froese, Rainer; Pauly, Daniel (eds.) (2009). "Caranx lugubris" in FishBase. October 2009 version.
–Smith-Vaniz, W. (1986). "Carangidae". In Smith, M.M.; Heemstra, P.C. (eds.). Smith's Sea Fishes. Berlin: Springer-Verlag. pp. 638-661.
–Randall, J.E.; van Egmond, J. (1994). "Marine fishes from the Seychelles: 108 new records". Zoologische Verhandelingen. 27: 43-83. PDF.
–Fricke, R. (1999). Fishes of the Mascarene Islands (Réunion, Mauritius, Rodriguez): an annotated checklist, with descriptions of new species. Koeltz Scientific Books. p. 759.
–Fischer, W.; Krupp F.; Schneider W.; Sommer C.; Carpenter K.E.; Niem V.H. (1995). Guía FAO para la identificación de especies para los fines de la pesca. Pacífico centro-oriental. Volumen II. Vertebrados - Parte 1. Rome: FAO. p. 953.
–Quattrini, A.M.; Ross, S.W.; Sulak, K.J.; Necaise, A.M.; Casazza, T.L.; Dennis, G.D. (2004). "Marine fishes new to continental United States waters, North Carolina, and the Gulf of Mexico". Southeastern Naturalist. 3 (1): 155-172.
–Lubbock, R.; Edwards, A. (1981). "The fishes of Saint Paul's Rocks". Journal of Fish Biology. 18 (2): 135-157.
–Carpenter, K.E., ed. (2002). The living marine resources of the Western Central Atlantic. Volume 3: Bony fishes part 2 (Opistognathidae to Molidae), sea turtles and marine mammals (PDF). FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes and American Society of Ichthyologists and Herpetologists Special Publication No. 5. Rome: FAO. p. 1438.
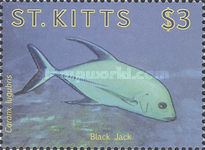
|
Data: 07/06/2010
Emissione: Flora e fauna Stato: St. Kitts |
|---|

|
Data: 06/04/1970
Emissione: Ittiofauna Stato: Ascension Island |
|---|

|
Data: 24/01/2006
Emissione: Pesca sportiva Stato: Ascension Island |
|---|

|
Data: 15/03/1997
Emissione: Ittiofauna Stato: Tuvalu |
|---|

|
Data: 22/02/1999
Emissione: Ittiofauna Stato: Micronesia |
|---|